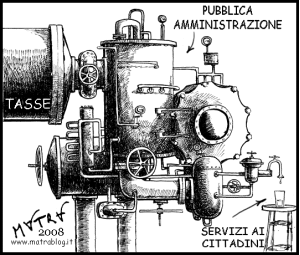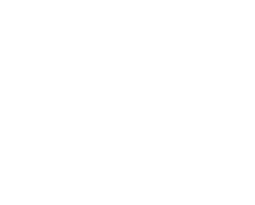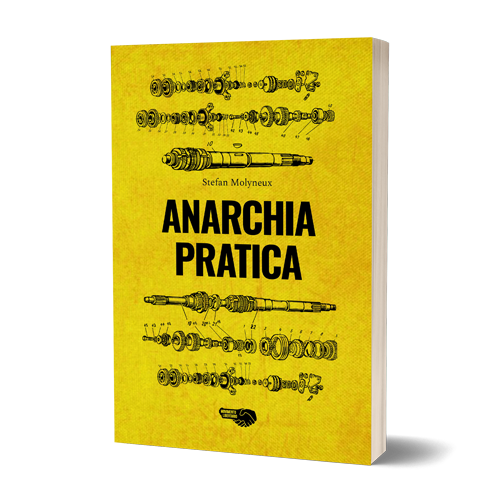Il ciclo della finanza pubblica si compone, strutturalmente, di due momenti distinti, ancorché necessariamente correlati ed indissolubilmente intrecciati. Sono due elementi che si tengono e si sostengono a vicenda. Metaforicamente le due facce, truci, della stessa medaglia. A monte, il processo si sostanzia propriamente nell’attività di imposizione, che genera, per l’appunto, le cosiddette “entrate pubbliche”. A valle, lo stesso si esplica e si esprime, lato uscite, nell’attività di spesa (la cosiddetta “spesa pubblica”).
Fin qui tutto chiaro e tutto scontato, verrebbe da dire. Nulla di sorprendente.
Ma, allora, perché lasciarsi andare ad un titolo, quello del presente intervento, così apparentemente caustico ed estremamente negativo? Perché definire un processo, che dal punto di vista teorico sembrerebbe così naturale ed innocente, addirittura come “perverso”?
Il perché è presto detto: seguitemi nel ragionamento e vedrete che quanto si andrà argomentando non potrà essere archiviato come una semplice boutade o catalogato come una mera provocazione, frutto dei pensieri in libertà di un eresiarca impenitente. Tutt’altro.
Tasse ed imposte: sono veramente una cosa bellissima, oltremodo necessaria “per comperare la civiltà?”
Una delle classiche argomentazioni a favore dell’ineludibilità e della necessità, fisiologica, di tasse ed imposte si basa sull’assunto che il contribuente, in corrispettivo delle stesse, “starebbe comperando la civiltà”, ed i vantaggi rivenienti dalla stessa. Ma è davvero così?
Di fatto, pur concedendo all’imposta di qualificarsi come una contropartita diretta e necessaria al finanziamento di quei servizi pubblici che il mercato, per qualsivoglia motivo, non fosse in grado di offrire, risulterebbe comunque del tutto incomprensibile la sua magnificazione quale strumento eletto, di più, come <<una cosa bellissima, un modo civilissimo di contribuire tutti insieme a beni indispensabili>>. A maggior ragione in un Paese, per dirla con Sergio Ricossa, in cui il cittadino sembra ricevere <<dallo Stato nient’altro che paccottiglia, al netto delle tangenti trattenute da privilegiati politici, burocrati, parassiti vari, dissipatori di ogni risma. C’è qualcuno infatti che sia soddisfatto dei nostri servizi pubblici, senza essere tra coloro che li forniscono?>>.
E che dire poi, quando al costo sostenuto per la generazione dei millantati benefici corrispondano esclusivamente spese per servizi che si dimostreranno per lo più inutili, scarsamente accessibili, se non del tutto indesiderati? E se, invece, in luogo dei soldi forzosamente esatti, venissero generate solo spese per scopi che non sono approvati, o addirittura nemmeno per quelli, in ragione del fatto che gli unici output prodotti dallo Stato fornitore sono sprechi, sperperi e dissipazioni?
Anche in questo caso staremmo comperando la civiltà, ovvero, molto più realisticamente, saremmo solo vittima di una truffa colossale, in ragione del fatto che, giuridicamente parlando, mancherebbe del tutto una causa di attribuzione patrimoniale?
Così come, ancora, sembrerebbe del tutto ingenuo, se non da sprovveduti, non accorgersi di quanto in realtà si celi sotto la patina speciosa e melensa che la vulgata corrente tende ad esaltare. Più che un insostituibile veicolo di redistribuzione perequativa delle risorse tra chi possiede di più e chi possiede meno o molto meno, quando non addirittura uno strumento principe di promozione sociale, la tassazione sottenderebbe, in realtà, ben altro. L’essenza e la natura dell’imposta, di fatto, sono ben diverse da quanto, e senza il benché minimo senso del pudore, la logica ortodossa imperante si ostini a sostenere. Non gli si attaglia alcuna mirabolante attribuzione né, tanto meno, alcuna taumaturgica vocazione.
Jean Baptiste Say ci aveva visto lungo, in tempi non sospetti. Che cos’è l’imposta?, si chiedeva più di due secoli fa il lungimirante economista transalpino. E la conclusione a cui giunse è ancor oggi una delle più efficaci ed adamantine spiegazioni che si possono dare del fenomeno.
È una palese assurdità pretendere che la tassazione possa contribuire alla ricchezza della nazione, assorbendo parte del prodotto interno, e arrecarne vantaggio consumandone parte della ricchezza.
La tassazione non è nient’altro che il trasferimento di una porzione delle risorse che costituiscono il prodotto nazionale dalle mani degli individui [che hanno contribuito a generarle, n.d.a.] a quelle del governo, con il proposito di assecondarne spese e consumi pubblici.
In qualsiasi modo la si voglia qualificare – non importa se tassa, contributo, dazio, imposta sui consumi, diritto doganale, contributo, sussidio, concessione o redistribuzione diretta – essa è di fatto un onere imposto a certi individui, non importa se sostenuto in forma individuale od aggregata (impresa), dal potere dominante in carica, con il pretesto di fornir loro i beni e i servizi che esso considera più adatti, a loro spese; in breve, trattasi di una cosa imposta, nel senso letterale del termine.
Spesa pubblica: una benedizione senza alternative, o semplicemente una immane traslazione forzosa di risorse da un gruppo sociale all’altro?
Parimenti, anche l’associata ed indissolubile nozione di spesa, quale logico e conseguente corollario nel ciclo di finanza pubblica, in realtà sottenderebbe ben altro, rispetto a quanto vanno dispensando gli innumerevoli statalisti interessati e i loro sodali di ogni genere e specie.
Hanno un bell’ardire, costoro, a beatificare l’imprescindibilità della spesa pubblica; ad esaltarne, entusiasticamente, i suoi principi costitutivi; a glorificare la meritorietà dei suoi mirabilissimi intendimenti.
Che non si sostanzierebbero soltanto nel finanziare la produzione di beni e servizi essenziali ed irrinunciabili, al fine di garantire il raggiungimento del tanto agognato bene comune; ma anche, secondo i sacri dogmi del keynesianismo imperante, tali intendimenti devono rinvenirsi tanto nella stabilizzazione e nello sviluppo del reddito dei singoli e delle imprese, quanto, ancor più auspicabile, in una più equa redistribuzione del reddito, per migliorare il benessere generale.
Solo lo Stato, di fatto, sarebbe in grado e può perseguire obiettivi di importanza così capitale: sono troppo grandi ed importanti gli interessi e i diritti in gioco, per poter essere lasciati in balia delle libere e volontarie dinamiche contrattuali e del naturale affermarsi delle regole della domanda e dell’offerta. Così come, ancora, solo l’intervento dello Stato può assicurare che si realizzi il conseguimento della “giustizia sociale” e dell’ “interesse collettivo”, per mezzo di un’allocazione compensativa di risorse, attuata mediante la tassazione generale e la regolamentazione coattiva, tra chi possiede di più e chi possiede meno o molto meno. Non fa nulla, da questo punto di vista, se la giustizia sociale sia un concetto di per sé sfuggente ed ambiguo, tanto ammiccante, perché stracarico di implicazioni positive, quanto inconsistente da un punto di vista pratico. E ancora, non fa nulla se le definizioni di bene comune e di interesse collettivo siano strumentalmente tautologiche: identificandosi, necessariamente, con <<quel che fanno i politici al potere, qualunque cosa facciano, compreso il rubare ai poveri per regalare ai ricchi>> (S. Ricossa).
Se ciò è vero, allora, a prescindere da come formalmente la si voglia configurare, la spesa pubblica finanziata con la tassazione costituisce pur sempre un’immane traslazione di risorse da un gruppo sociale all’altro; forzosamente prelevate a chi, quelle risorse, le ha prodotte e che da un momento all’altro, quando va bene, se le vede svaporare senza nemmeno sapere il perché e, quel che è ancora peggio, senza potere avere la benché minima voce in capitolo.
Di più, come si può facilmente constatare se solo si ponesse un minimo di attenzione alle consuete manovre che vedono i politici di ogni schiarimento impegnati a far di tutto pur di accaparrarsi voti e consenso, risulta ormai palmare che sia i trasferimenti redistributivi diretti, che tutte le altre forme di impiego, genericamente riconducibili sotto l’omnicomprensivo cappello di “spesa pubblica”, concretizzano logiche di intervento che, di per sé, prestano il fianco a delle critiche difficilmente sormontabili.
Poiché, se da un lato, i trasferimenti redistributivi diretti generano, ex nihilo, un processo di distribuzione parallelo, in virtù del quale i percettori dei benefici possono lucrare gli “extraprofitti” rivenienti dalla dissociazione tra la remunerazione accaparrata e lo sforzo applicato per ottenerla, dall’altro qualsiasi intervento destinato ad alimentare la spesa è fisiologicamente viziato da una tara genetica ineliminabile: ravvisabile ogniqualvolta lo Stato si prodighi ad intraprendere, organizzare, gestire qualsivoglia tipologia di intrapresa economica. Di fatto esso detiene, invariabilmente, la facoltà di reperire risorse illimitate a proprio capriccio, sulla scorta del suo sterminato potere coercitivo di tassazione. A differenza di qualsiasi intrapresa privata non ha alcuna necessità né di tenere a freno la sua sconfinata libido taxandi, né, tanto meno, di sposare processi valutativi del tipo “trial and error”, per testare l’effettiva bontà dei servizi somministrati ai consumatori; così come può sicuramente evitare di approntare i mezzi più opportuni ed efficaci per intercettare i loro desideri, e quindi i loro euro, nel rispetto della logica della corrispettività di prestazioni mutualmente vantaggiose e delle esigibilità reciprocamente concordate, originate dalla costruttività di scambi liberi e volontari.
L’illusione finanziaria
Ma se le cose stanno effettivamente così, come sarà mai possibile che i tax payers non si rendano conto del grande imbroglio di cui sono vittime? Come si può razionalmente giustificare il fatto che si sopportino, senza colpo ferire, sacrifici ed oneri incontrovertibilmente superiori ai vantaggi attesi ed auspicati?
Nel 1903, un grande economista italiano, Amilcare Puviani, elaborò per primo la teoria della “illusione finanziaria”, ovvero della <<rappresentazione erronea delle ricchezze pagate o da pagarsi a titolo d’imposta o di certe modalità del loro impiego>>. Il fenomeno in parola determina una serie di distorsioni percettive e di asimmetrie informative, il cui affermarsi è però determinante per la tenuta del sistema: perché concorre parallelamente sia a favorire la stabilizzazione e la crescita incontrollata degli impulsi al tax spending, sia ad alimentare il circuito vizioso del ricorso ad infinitum all’interventismo pubblico.
Da una parte, infatti, il produttore-contribuente, in qualità di pagatore ignorante ed inconsapevole, non è assolutamente in grado, se non per via di percezioni superficiali e sottostimate, di stabilire “chi paga che cosa”. Ovvero, a fronte della complessità, dell’articolazione e della nebulosità dei mezzi, degli strumenti e dei meccanismi impiegati, gli è pressoché impossibile muoversi nel dedalo infernale di un impianto normativo e regolamentare, volutamente reso e mantenuto inestricabile ed incomprensibile, per determinare oggettivamente: l’entità del prelievo cui si è andati incontro (“a quanto ammontano le tasse”); le modalità di esazione e i criteri di imputazione con cui si è integrato il prelievo (“quali sono e come vengono riscosse le tasse”); la destinazione e la finalità dello stesso (“a chi vanno e a cosa servono le tasse”); la correlazione sussistente tra l’entità del prelievo e l’entità di quanto ricevuto in contropartita (“cosa ho effettivamente ottenuto in cambio delle tasse corrisposte”).
D’altro canto, lo stesso soggetto sarà indotto ad attivare delle dissociazioni comportamentali schizofreniche e ad operare in base a percezioni autoreferenziali e distorte, in funzione della sua propensione a ricercare, di volta in volta, quelle utilità e quei vantaggi attesi, che egli reputa si possano utilitaristicamente estrarre dalle pieghe di un provvedimento e/o di una politica, solo per il fatto che stimi di appartenere, da un punto di vista posizionale, alla categoria protetta e tutelata dall’intervento.
Ergo, quello stesso individuo sarà portato a credere che <<le singole persone sono tenute a mantenere lo stato e solo in esso a trovarvi, se lo trovano, il proprio comodo>> (L. Fressoia): confidando ed illudendosi, in un modo o nell’altro, di riuscire ad estrarre dallo Stato, o dalle pieghe dei suoi capitoli contabili, quei privilegi, quei benefici, quelle retrocessioni che possano quanto meno compensare i costi sostenuti per il suo mantenimento ed il cui valore stimato sia in grado, se non altro, di riportare in pareggio il proprio personale bilancio.
Quindi, se per un verso, come ha ben evidenziato Andrea Papi,
Tutto ciò è possibile perché i cittadini sono esclusi da ogni decisione in proposito e dai controlli sui vari movimenti di denaro pubblico. Così siamo sottoposti alla condizione, per nulla eclatante, che ci viene imposto di contribuire a spese che dovrebbero riguardare il benessere collettivo, avendo di fatto l’obbligo di contribuire a un pozzo senza fondo, che non abbiamo voluto e che non possiamo controllare, per trovarci pieni di debiti e di tasse, sia dirette che indirette, fra l’altro continuamente in aumento.
Dall’altro, rifacendoci alle parole di Giacomo Reali, è sicuramente comprovata la teoria della “personalità economica multipla”, elaborata da Henry Hazlitt:
…secondo la quale il modo di ragionare di una persona e le sue richieste allo Stato variano a seconda della posizione che l’individuo immagina di occupare rispetto a una particolare politica: i cittadini sono, effettivamente, insieme produttori, consumatori e contribuenti e spesso non realizzano che le richieste che avanzano allo Stato su un fronte si contraddicono con le esigenze che hanno su altri fronti.
Ciascuno pensa che potrà valersi delle varie combinazioni politiche di sussidio o regolamentazione così da guadagnare con la sovvenzione/protezione più di quanto non debba perdere con l’imposta che serve a finanziarle, ma s’inganna, perché la politica economica dirigista non è a somma zero, ma a somma negativa: a lungo termine ci perdono tutti, perché tale politica contrae la produzione, aumenta il livello di tassazione e, quindi, distrugge ricchezza e blocca la crescita.
Conclusioni
Una volta di più, e come sempre allorché lo Stato si arroga il diritto di intervenire in ogni ambito del viver civile, si ravviserà la tipica “epifania” del drastico stravolgimento delle regole auree dell’efficienza economica e del libero e volontario scambio delle risorse. Se da una parte, infatti, <<ogni redistribuzione, qualunque sia il criterio sul quale essa si fonda, implica che si prende ai [legittimi] possessori e [legittimi] produttori originari (coloro che “hanno”qualcosa) per dare ai non- possessori e non- produttori (coloro che “non hanno” la cosa in questione)>> (H. H. Hoppe), dall’altra essa sovverte principi cardinali e norme basiche ai fini dello sviluppo e del mantenimento di feconde interazioni interindividuali: che si identificano nel riconoscimento assoluto dei diritti di proprietà privata sulle risorse scarse, legittimamente acquisite, impiegate e messe a profitto da ogni singolo individuo, e nell’osservanza consapevole dell’insostituibile principio orientativo del “do ut des”. In potenza del quale, rifacendoci a Ludwig von Mises, <<nella società la cooperazione sostituisce lo scambio interpersonale o sociale agli scambi autistici. L’uomo dà ad altri uomini per ricevere da essi. La reciprocità si afferma. Si serve per essere serviti. La relazione di scambio è la relazione sociale fondamentale. Lo scambio interpersonale di beni e servizi tesse legami che uniscono gli uomini in società>>.
È indubbio, allora, che una alterazione di un simile complesso di regole non possa che comportare, ineluttabilmente, che vi sia <<meno appropriazione originaria di risorse la cui scarsità è nota, meno produzione di nuovi beni, meno sfruttamento dei beni esistenti, meno contratti e meno commerci reciprocamente vantaggiosi. E questo conduce naturalmente verso un più basso tenore di vita in termini di beni di mercato e di servizi>>(H. H. Hoppe).
In altre parole, l’estorsione sistemica e sistematica di risorse, necessarie ad alimentare il sistema corrotto e degenerato, non solo preclude ai loro legittimi proprietari – ovvero a coloro che quelle risorse le hanno create, acquisite e legittimamente costituite- la possibilità di impiegarle in utilizzi alternativi (esercizio di immediati atti di consumo, anziché intrapresa di atti volti al risparmio e/o all’investimento produttivo), stimati da loro, e non da un burocrate irresponsabile, come più meritevoli e desiderabili.
Di più: ancorché, come già detto, non vengano quasi mai del tutto avvertite l’essenza e l’entità del taglieggiamento cui sono sottoposti, è ugualmente vero che la sola percezione, sottostimata, del fenomeno può scoraggiare, e comunque limita, i tax payers ad affidarsi ai naturali strumenti di cooperazione e di collaborazione, che costituiscono pur sempre il presupposto basico per la nascita e per lo sviluppo dei rapporti di interazione sociale, ai fini del soddisfacimento dei bisogni individuali nella maniera più completa possibile.
Anzi, l’assenza di indici fondamentali e di condizioni indispensabili per l’applicazione del calcolo economico non può che corrompere il carattere degli agenti, i quali saranno indotti a ricercare certezze e stabilità, elementi che non si ha più garanzia di acquisire attraverso l’esercizio dei naturali mezzi economici, rifugiandosi nell’illusorio porto sicuro offerto dai mezzi politici.
Ecco, quindi, dove sta il male assoluto, in tanto subdolo in quanto latente.
Prodigandoci per ottenere soluzioni che possano incontrare il favore del canale politico, non solo si sta manomettendo la nostra più ampia libertà di scelta, perché dismettiamo risorse, capacità ed energie che avremmo potuto impiegare in ben altre strategie cooperative: nel creare, produrre, comprare, vendere, scambiare, scartare beni e servizi senza vincoli di sorta e come meglio ci avrebbe aggradato e soddisfatto, in termini di profitto materiale e psicologico, nel rispetto delle libertà individuali e in accordo alle reciproche esigibilità.
Ma stiamo allargando sempre più, e sempre più a dismisura, la presa mortale dello Stato e della sua ancor più esiziale espansione, che diventa vieppiù invasiva e pervasiva, ingerendosi in maniera totalizzante nelle nostre vite.
Hayek, del resto, lo aveva ben previsto: solo la decentralizzazione del potere <<equivale a ridurre l’ammontare assoluto del potere, e il sistema basato sulla concorrenza è l’unico sistema destinato a ridurre al minimo il potere esercitato dall’uomo sull’uomo>>.
È da troppo tempo, ormai che si viaggia contromano: ci si sta cucinando da noi la ricetta più infallibile per il declino ed il fallimento sicuro.
* Link all’originale: http://www.lindipendenza.com/tasse-finanza-pubblica/