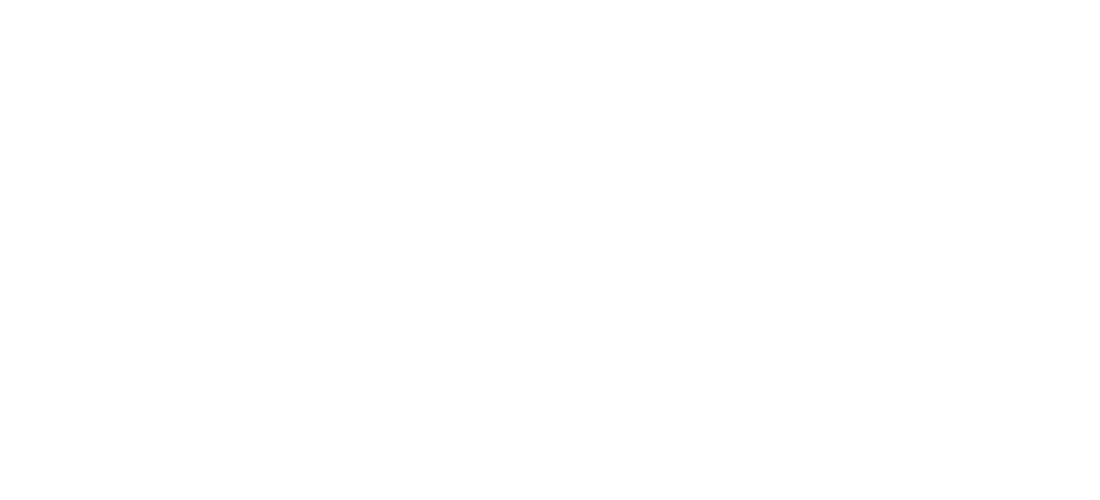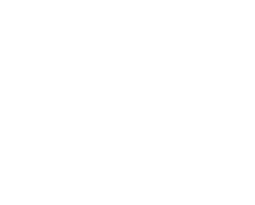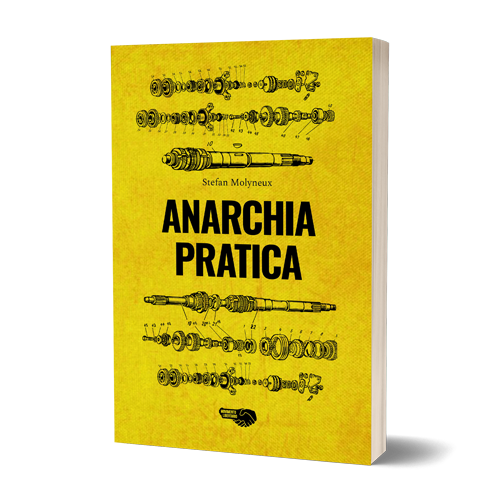La riflessione che segue è il frutto acerbo e mai conchiuso di un giuoco intellettuale, quello nel quale i valori scelti da Italo Calvino per la letteratura del Terzo Millennio (leggerezza, esattezza, rapidità, visibilità, molteplicità) sono catapultati, in una sorta di transmutazione estetica, nella politica.
L’assenza, nel titolo, di attributi a corredo del sostantivo ‘politica’ è puramente causata: per essere questo il tempo in cui l’attenzione ai concetti deve precedere lo scrupolo per le definizioni; e per essere tanto retorica l’enfasi normalmente prestata ai progetti di una nuova politica, almeno quanto la cronaca successiva è prodiga di fallimenti.
Aggiungo soltanto che sarebbe bello se l’esercizio potesse arricchirsi di ulteriori interpretazioni e declinazioni, secondo le idee, la fantasia e la sensibilità di ciascuno.
1. Leggerezza
“(…) La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio”, afferma Calvino nelle sue “Lezioni americane”. Formulando l’opposizione leggerezza-peso con riferimento alla politica, quasi nessuno – credo – sosterrebbe la polarità del peso: qualcuno per demagogia e senza onestà intellettuale; molti di più con onestà intellettuale ma senza valutarne le possibili conseguenze. Politica leggera potrebbe implicare uno Stato leggero, anzi ‘minimo’ – come proposto da Robert Nozick quasi 40 anni fa. In “Anarchia, Stato e Utopia” egli affida allo Stato, attraverso il monopolio legittimo della forza, il solo compito di protezione dei diritti individuali. La politica ne uscirebbe inevitabilmente ridimensionata, anche se il termine greco politikós (cioè: relativo al cittadino) allude ad una realtà più ampia del perimetro di intervento dello Stato.
Una politica leggera certamente non ha costi per il contribuente ma solo per il sostenitore. Implica l’abolizione di ogni e qualsiasi finanziamento pubblico, il cui meccanismo vìola perlomeno l’aspettativa di coloro che, non partecipando al voto, non intendano sostenere alcun competitor. In realtà, attraverso la tassazione – e, quindi, mediante coercizione – essi provvedono comunque al sostentamento (neppure di un partito, bensì) di tutti i partiti in Parlamento.
Molti (per lo più amici del giaguaro) dicono che l’abolizione del finanziamento pubblico lascerebbe la politica in mano a pochi tycoons. Come se non fosse già diretta o controllata da singoli che intrattengono con il partito un rapporto di tipo proprietario ovvero da corporazioni e gruppi di interesse, mentre estromette sistematicamente i suoi forzati sostenitori: i cittadini.
Il destino degli apparati potrebbe risultarne compromesso? Sinceramente non sarebbe ragionevole condizionare questa novità al problema lavorativo di svariate centinaia di funzionari assunti dai partiti: la loro vicenda non è a priori più significativa di quella di migliaia di artigiani, di operai, di lavoratori autonomi che quotidianamente cessano di lavorare nell’indifferenza generale.
Leggerezza in politica dovrebbe significare una legge elettorale semplice: quella con collegi uninominali a turno unico, per esempio. Con gruppi di opinione che si organizzano come credono in vari soggetti tra loro contrapposti con i rispettivi candidati.
Leggerezza è guadagnare al cittadino… anzi è il cittadino che conquista un rapporto con la politica sempre più ‘bottom-up‘ e sempre meno ‘top-down‘. E con esso potere di scelta, di iniziativa e di controllo non nominali. Anche, perché no, mediante l’utilizzo di istituti di democrazia diretta combinati con la tecnologia. Dove la sfida della leggerezza potrebbe dirsi comunque vinta ma, per il momento, senza il contrafforte di adeguate garanzie. Varrebbe allora la pena di aggiungere un po’ di peso: quello delle regole a tutela dell’affidamento, quanto meno dei terzi di buona fede.
2. Esattezza
L’esattezza si nutre della competenza e si esprime in chiarezza. Senonché il politico è sovente ignorante come una “capra” (il sostantivo stra-lanciato da Vittorio Sgarbi non dispiace, con il dovuto rispetto al placido animale) e per questo, sorprendentemente, non c’è cosa che si precluda al suo giudizio: il nulla che pretende di occuparsi di tutto, fermandosi alla superficie delle cose. Magari prima di diventare tale il politico aveva un mestiere, una professione; era insomma specialista di qualcosa. Ma aveva capito che la politica non richiedeva tutto questo e forse vi è entrato apposta, per non dover (più) sostenere la fatica della competenza, di un mercato sufficientemente aperto da tenerlo in tensione e metterlo in crisi. Da lì ha iniziato, qualora non fosse già “capra”, un processo di progressivo svuotamento perché il cervello, come un muscolo, si atrofizza mediante il non-uso e la conquista del potere è allergica alla competenza: è un vuoto che divora il pieno, un generalismo tuttologo che spande il proprio miasma sull’universo scibile.
Non si fatica a spiegarsi il fenomeno, già ampiamente sondato (con riferimento alle carriere aziendali) dallo psicologo canadese Laurence J. Peter che, insieme a Raymond Hull, aveva elaborato nella seconda metà del secolo scorso una teoria dell’incompetenza che aderisce come un guanto alla politica: “in ogni gerarchia, un dipendente tende a salire fino al proprio livello di incompetenza”; (…) “tutto il lavoro viene svolto da quegli impiegati che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di incompetenza”. Vi piace l’accostamento?
L’incompetenza genera l’impossibilità dell’esattezza. Come si fa ad essere esatti circa qualcosa che non si conosce o non si comprende? Questa autentica ‘rovina’ sociale ed umana ha come corollario un linguaggio connotato da un alto tasso di astrattezza, da una retorica mediocre che indulge anche a considerazioni viete ed è vago, fumoso, incomprensibile. Ove usato nei rapporti tra privati, ci sarebbe il rischio di passare da dementi.
Se la politica tornerà un giorno ad ‘oggettivarsi’, nel senso di prestare una attenzione immediata alle cose da fare piuttosto che alle vuote ragioni di questa o quella fazione, dovrà meritare il consenso a partire da ciò che propone. Su quali altre basi, altrimenti? E a quali riferimenti dovrebbe attingere il potere di controllo dal basso – dagli iscritti eppoi dagli elettori -, se non dalla puntualità, dalla specificità delle cose proposte? L’esattezza dischiude così un controllo di coerenza e spiega perché, quando possibile, i politici vogliono eluderla. Non solo, dunque, per necessità (l’ignoranza) ma anche – pur se meno “spessamente” (come direbbe Cetto La Qualunque, l’esilarante ‘lider’ di Antonio Albanese) – a sommo (si fa per dire) studio.
Sia chiaro: c’è da dubitare che l’esattezza possa mai rientrare (ammesso che ne abbia mai veramente fatto parte) nel pianeta della politica perché è ‘fedeltà’ il nome della sua signora e padrona. Ciò almeno fino a quando, per la inedita drammaticità della situazione, non farà una comparsa da protagonista il gusto di risolvere alcuni gravi – ove non già insuperabili – problemi di interesse comune; perché il carburante segreto dell’esattezza è proprio la passione civica e il senso critico e la rettitudine di giudizio sono le sentinelle che ne custodiscono lo slancio da ogni malintesa obbedienza.
3. Rapidità
Questo è l’effetto che mi fa… la rapidità: rapidità, come velocità, mi rimanda a Filippo Tommaso Marinetti (“O tenebrose pianure!… Io vi sorpasso a galoppo!… / Su questo mio mostro impazzito!...”). Nel nostro tempo, ove l’Information and Communication Technology muove la rapidità con i byte ed è capillare, insidiosa, omnipervasiva, è come se l’estetica futurista avesse ottenuto un trionfo – ancorché postumo.
Come si rapporta, dunque, la rapidità con la politica? La politica è tradizionalmente procedure di formazione del consenso: un tempo partivano dal basso ed erano lente. E’ dialettica finalizzata alla selezione di idee e progetti: un tempo erano oggetto di confronto serrato. Che cosa è rimasto, oggi, di questa ‘lentezza’? La rapidità potrebbe essere un concetto positivo, un fattore competitivo nella politica, ammesso che volesse significare lettura intelligente, tempestiva della realtà e delle sue prospettive per anticipare, non inseguire, gli eventi. In questo senso nulla – sembra – è cambiato: la classe dirigente – e con essa parte significativa del Paese – è rimasta al passo del tempo che fu; nel frattempo, il mondo ha preso letteralmente a correre e dunque ci ritroviamo in ritardo di anni-luce, non dal futuro ma dal presente. Anche questo procura la sgradevole percezione del piano inclinato.
Qualcuno ha preso un abbaglio, deve aver confuso la rapidità con qualcos’altro. La politica è divenuta fisiologicamente incostante, una impudente banderuola; i media straboccano di sparate, improvvisazioni, frasi ad effetto seguite a poca distanza da correzioni, smentite; e poi colpi di teatro, improvvisi pentimenti, mutamenti di scenario. E’ chiaro che si tratta di fuochi fatui. Tutto è effimero, inconsistente, fasullo – rapido nel formarsi e nel dissolversi. Dietro c’è il niente, il vuoto pneumatico: facile sposare la rapidità a queste condizioni, no?
Essa solo apparentemente è sussunta dalla politica in quanto, pur volendo essere virtuosa, è confusa spesso e volentieri con l’ambigua mutevolezza. A ciò si aggiunga quello che Italo Calvino, nelle sue “Lezioni americane”, chiama “l’espandersi della peste del linguaggio”; un’epidemia che si manifesta come “perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze”. Questa malintesa rapidità non è altro che un nuovo, insopportabile conformismo; torna dunque preziosa la lezione di Piero Gobetti quando afferma che “il contrasto vero dei tempi nuovi come delle vecchie tradizioni non è tra dittatura e libertà, ma tra libertà e unanimità: il vizio storico della nostra formazione politica consisterebbe nell’incapacità di pesare le sfumature e di conservare nelle posizioni contraddittorie un’onesta intransigenza suggerita dal senso che le antitesi sono necessarie e la lotta le coordina invece che sopprimerle”. A che giova la rapidità, se deve sobbarcarsi il peso del nulla, dell’indistinto?
4. Visibilità
Spiega Italo Calvino di aver incluso la visibilità nel proprio elenco di “valori da salvare” per avvertire del “pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi” come conseguenza della “civiltà dell’immagine”. L’osservazione può ben prestarsi all’ambito qui trattato: la politica si esibisce ogni giorno, distribuisce una quantità immane di parole e di immagini, eppure sentiamo che l’alluvione è buona soprattutto a frastornarci, è fasulla, cioè non è portatrice di significati autentici. Al contempo verifichiamo che spesso, dentro di noi, la pretesa di qualcosa di diverso è vinta da frustrazione e rassegnazione, dall’abitudine di pretendere la novità da qualcuno che non siamo noi o da qualcosa che non dipende da noi.
Ecco, il problema della visibilità s’impone come questione fondamentalmente individuale e si lega all’idea che la situazione attuale (fatta di istituzioni, norme, procedure, prassi, sentire comune, cultura e/o pensiero dominanti) sia l’unica merce in circolazione; un’idea errata, fuorviante, pericolosa e per ciò sussidiata e indotta dal bombardamento mediatico.
Il circolo è vizioso: la carenza di pensiero critico e di immaginazione, di lucidità e al contempo di passione, è un formidabile incentivo allo spirito già conservatore di chi detiene il potere e spiana la strada a chi, volendolo conquistare, intenda cacciare qualcuno al solo fine di sostituirlo. La visibilità massiva, la sovraesposizione incessante di persone e fatti, stordiscono le persone e velano il vuoto totale di intraprendenza creativa, la totale accondiscendenza della classe dirigente allo status quo, l’indisponibilità di fatto – oltre gli annunci e le promesse – a introdurre cambiamenti sostanziali.
La capacità di ‘immaginare’, di ‘vedere’ la o le alternative mi fa aderire in un certo senso allo slogan sessantottino della “immaginazione al potere” – purché qui sia chiaro che non si tratta di fare sogni ad occhi aperti pensando di sovvertire la natura delle cose – a cominciare da quella umana. L’immaginazione non può sprecarsi nell’abbozzo di un’utopia, deve essere impiegata per sollevare dall’oblio le potenzialità inespresse ma concretamente attivabili dentro la realtà, nella quale non è mai irreversibile la scelta della strada imboccata. Detrarre la ‘vis utopica’ dal ‘sogno’ serve a garantire fattibilità all’idea – senza deprimerne l’appeal. La “vision” (per usare un termine a suo tempo appreso dall’ottimo Franco D’Egidio) sia dunque il prodotto di una ricerca, di un approfondimento, comunque di un procedimento razionale ma si appresti allo stesso tempo ad intercettare le qualità irrazionali, l’adesione profonda, emotiva di ciascuno.
Per quanto sin qui detto, la sfida dell’innovazione e del cambiamento non può essere ‘delegata’ ad un “leader della rivoluzione” (titolo di un brillante testo di Gary Hamel) – che il tema sia quello di una nuova organizzazione statuale o di una ristrutturazione aziendale non fa molta differenza -, pena l’incorrere in uno dei due rischi: 1) il leader “c’è” ma alla fine non ha séguito perché non è compreso, ovvero: 2) il leader muove il consenso, sì, ma lo utilizza per fare qualcosa di diverso dalla ‘rivoluzione’.
Questo concetto di ‘visibilità’ mi piace, dunque, perché è di segno spiccatamente individualista, nel senso migliore del termine: chiama ciascuno a fare qualcosa, a riappropriarsi del ‘proprio’ potere per cambiare ‘il’ potere, a partire da una responsabilità inalienabile: quella di non limitarsi a criticare la minestra che non piace ma pensare, desiderare e ‘visualizzare’ un piatto diverso quale primo passo per cambiare la cucina, insieme – naturalmente – ai cuochi.
5. Molteplicità
A chiusura del ‘pentalogo valoriale’ Italo Calvino propone un concetto che qui diventa decisivo ed è – forse per ciò – il più critico tra gli altri. Se nella nostra epoca la letteratura si è fatta carico dell’antica ambizione di “rappresentare la molteplicità delle relazioni” e se oggi non è più pensabile – ammesso che lo sia mai stata – “una totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima”, la politica ha percorso il tragitto inverso, dimenticando che ciascuno di noi è persona e individuo (due concetti – l’uno caro alla tradizione cristiana, l’altro alla tradizione filosofica liberale – prossimi e reciprocamente vivificanti) e cioè qualcosa di inconfondibile e irripetibile. Perché affermare questo? Perché in ossequio all’individualismo ‘ontologico’ (riproposto da Frederick von Hayek e da Karl Popper) non esiste, propriamente, la ‘società’ ma esistono milioni di ‘uomini’ in carne ed ossa – ciascuno portatore di valori, preferenze, bisogni, talenti, virtù – legati l’uno all’altro da nessi diretti e indiretti, intenzionali e inintenzionali; per conseguenza (individualismo ‘metodologico’), non è corretto trattare gli insiemi e le istituzioni sociali – che notoriamente non hanno né parola, né volontà – come la chiave di lettura dei fatti e degli accadimenti reali.
La politica ovvero i politici, attraverso lo Stato e la legislazione statuale, hanno condotto una guerra senza quartiere verso la ‘molteplicità’; hanno dato vita o agevolato un processo perverso di massificazione di cui le opinioni, i comportamenti e il linguaggio recano tracce sempre più profonde. Bruno Leoni nel suo “La libertà e la legge” ha spiegato che “nella società contemporanea sembra essere stato violato un principio antichissimo, già enunciato dal Vangelo e, molto prima, dalla filosofia confuciana: ‘non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te’.” Certo, scoprire che cosa la gente non vorrebbe che altri le facesse non è agevole, però è sempre più facile che determinare “che cosa la gente vorrebbe fare da sé o in collaborazione con altri”. “La volontà comune, concepita come la volontà comune a tutti e a ciascun membro della società, si può accertare molto più facilmente, per quanto riguarda il suo contenuto, nella maniera ‘negativa’ già esposta dal principio confuciano che in qualunque altra maniera ‘positiva’”. Ecco perché nella ‘dicotomia della libertà’ tra ‘negativa’ (quella dalla costrizione/interferenza da parte di altri uomini) e ‘positiva’ (ad esempio quella dal bisogno, sempre più maliziosamente evocata), Isaiah Berlin non dubitava che solo la prima costituisse ‘libertà’ in senso autentico. Si debbono comprendere e rispettare le diversità e la molteplicità (una molteplicità fatta di soggetti ma che insiste, in una combinazione di volta in volta originale, anche dentro ciascuno di loro), trattandosi di evidenze irriducibili che lo Stato non sa, non può – e, si può perfino dire, non è tenuto a – conoscere.
Ecco: l’impegno politico deve ripartire da qui; dall’obiettivo di distruggere pezzo per pezzo (prendendo da Leoni un concetto azzeccato) la ‘mitologia’ della legge, dello Stato, come emersa dal lungo e travagliato laboratorio del XX° secolo. Questa radicale decostruzione non può ignorare il tema cruciale della rappresentanza e va al cuore stesso della democrazia – almeno per come sviluppatasi nell’Occidente moderno – per la sua ormai acclarata inettitudine a mantenere la promessa di libertà e di benessere che l’aveva iniziata.
__________
(già pubblicato in 5 puntate su “Cultura Commestibile”, anno 2013, nn. 48, 52, 53, 54 e 55)